«Che la morte ti accolga / con tutti i tuoi sogni intatti», scrisse Álvaro Mutis in una poesia compresa nella raccolta Le opere perdute. E nonostante i suoi novant’anni (era nato a Bogotá nel 1923) pare proprio che l’ora estrema (è morto il 22 settembre) l’abbia colto nell’intangibilità dei suoi propositi e delle sue visioni. Poi, ovviamente: «La morte confonderà i tuoi sogni / e in essi riconoscerà i segni / da lei lasciati un tempo, / come un cacciatore che di ritorno / riconosce le sue tracce sull’aperto sentiero».
Ritenuto un maestro della letteratura ispano-americana, Mutis («scrittore e poeta della stirpe più rara, ricco senza ostentazione e senza spreco», lo definì Octavio Paz), per un lungo tratto della sua operazione narrativa si è fatto accompagnare da una sorta di “doppio” (ma guai a dirgli che era il suo alter ego), Maqroll il Gabbiere, simbolo vitale dell’anarchico errante, eroe e antieroe di quasi tutte le sue storie, titolare di mille iniziative e derive lungo le mappe del continente, in una sorta di strategia dell’esilio stabile, irrimediabile, duraturo. Maqroll, donchisciottesco artefice delle vele e delle attrezzature marinare, destinato a una inevitabile sconfitta, risulta poi vincitore nelle circostanze della propria vita: re della cronaca, ma anche del prodigioso e dell’avventuroso, in un seguito di azioni, meditazioni, gesti e riflessioni, per scali sperduti e mete inquietanti, Maqroll è l’umanissimo semidio del coraggio e della sfida (e dentro l’operazione letteraria, il protagonista di un macrotesto costruito per romanzi, racconti, poesie: essere che interpreta la propria miseria come fonte di conoscenza e di fertile permanenza della verità lungo i profili del mondo variabile e ingannatore).
Il viaggio, infatti, è stato rito e mito di Mutis, ragazzo e uomo, tra Europa e Colombia, amore per le navi e per il mare, niente studi superiori ma libertà di leggere in piena soddisfazione della mente e dello spirito.
Da La baldanza (1948) suo primo libro scritto a quattro mani con Carlos Patiño Roselli, sino a Storie della disperanza (2003), per non dire delle già citate Opere perdute (2009), la sua quarantina di titoli è presente nelle principali lingue del mondo, anche perché pluripremiati — dal Medicis all’Asturias, dal Reina Sofia al Cervantes al Grinzane, e più volte in odore di Nobel — a rappresentare la sua visione della vita tra «materia» e «ordine», dove la prima sta per il tema della «disperanza», appunto, scelta esistenziale senza radici e aperta all’imprevisto, e il secondo per una tal quale maturazione di fede religiosa, certezza di un destino finale, ordinato quindi, e provvidenziale.
«Esercizio del mistero», così chiamato dai critici a indicare ciò che rimane della facoltà creativa quando si è sul punto di “soccombere” alla presenza divina, il versante religioso di Mutis è stato meglio definito come «trascendentalista». Innalzandosi sulle forme estreme della condizione umana (i suoi «ospedali d’oltremare»), egli accede a una ricerca spirituale, impersonata dal suo Maqroll, attraverso paesaggi captati come luoghi psichici prima di approdare al mistero taumaturgico del profondo (in linea col pensiero analitico del sé junghiano).
Fascino del mistero tra squarci d’illuminazione, ma non meno parentesi di dolori, sconfitte, tradimenti (miseria e grandezza della peripezia umana), Mutis ha più intensamente di altri vissuto il suo tempo terreno proprio perché si è sempre messo in condizione di non attendersi mai nulla dalla vita, cogliere l’attimo prima di perderlo, ma non per mero opportunismo morale, piuttosto per essere libero dallo scudo dell’illusione, dare forza etica al comportamento, disubbidendo alle norme imperfette degli uomini, ma non alla legge superiore.
Amicizia, amore, memoria dell’infanzia, incanto della natura, stupore della vita, fiducia in una soluzione al di là delle contingenze, daranno alla “disperanza” i debiti accenti contro la disperazione o, peggio, la gioia immotivata. Tra il paradiso dell’età verde e l’inferno della maturità (sarà anche in carcere per una controversa appropriazione di denaro da cui verrà assolto); tra l’angolo di terra di Tolima nell’azienda del nonno dove nascono i sogni e le nostalgie («Il tropico, più che un paesaggio o un clima è un’esperienza»), e la realtà del mondo che brucia nella guerra totale, Mutis rifiuta alla sua scrittura la qualifica di “realismo fantastico” o di “nuovo romanticismo”, e tanto meno di “esotismo” (semmai, il suo è un “realismo magico”, o un “reale meraviglioso”).
La sua letteratura è un invito alla lucidità, alla lotta dei corpi e non dei fantasmi, alla condanna del mondo non attraverso effimeri miraggi, utopie, chimere. Il suo «odio», e la parola non va sostituita perché è sua, verso la modernità, la tecnologia, la disumanizzazione della società d’oggi, il sinistro desiderio di potere delle attuali ideologie, non alludono, né tanto meno fanno spazio, a migliori mondi immaginari, ma chiamano a presenti e pressanti resistenze.
Difettava di speranza, come normalmente è intesa, perché la assimilava all’inganno della storia, a un castello di sabbia, a una sorta di droga che rigetta il caso, la sorpresa, la fatalità: tutti eventi, invece, concretamente iscritti nel destino dell’uomo.
dall’Osservatore Romano del 26-9-2013

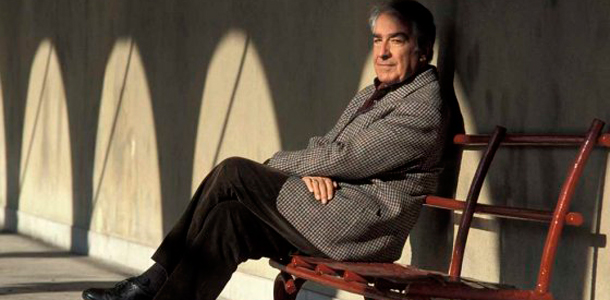
 ametalli@gmail.com
ametalli@gmail.com

